La poesia come ricerca, 1990
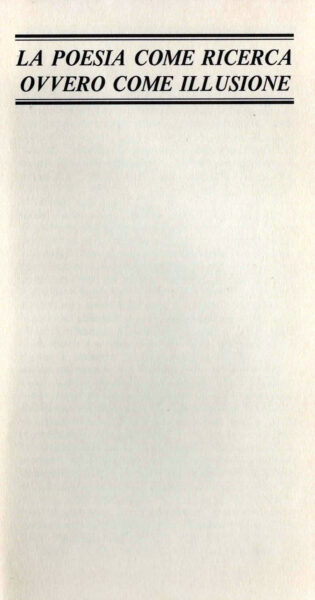
Sapremo ancora a cosa serve la poesia se la poesia non si legge? Lo dicono gli editori. Lo dicono i librai. Lo dice l’assenza di lettori. La poesia ha fatto la stessa misera fine della filosofia. È opinione corrente che l’una e l’altra guardino al mondo astrale. Un’opinione spicciola, liquidatoria. Il guaio è che risulta essere opinione comune. Siamo ormai demotivati verso quelle allegorie, quel gioco verbale, quelle astuzie, quelle astrazioni, quegli alambicchi dalle rime baciate, incatenate, alternate o liberamente dispiegate nell’indagine pura della parola che vale “di per sé”. Come potremmo riaprire quel dialogo interrotto? Dove si nascondono i lettori? I poeti in esilio, consapevoli di essere pregiudizialmente ignorati, hanno chiuso i testi nel cassetto in attesa di tempi migliori. A che serve la poesia? A niente. A creare delle illusioni, a catturare i sensi, a risvegliare i sogni, a riaccendere i fuochi e ad attizzarli, a sprofondare nell’inconscio, a catturare le immagini, a fotografare la luce, a rubare i colori. A niente e a tutto. Proprio come la filosofia. È il destino di entrambe. Da qui la scarsa credibilità. La poesia non dà risposte ma le cerca. Noi vogliamo delle certezze. Almeno per farla uscire dal suo esilio dobbiamo essere pronti ad aprire un dialogo. Non potrà uscire se mancherà l’interlocutore. Per aprire un dialogo occorre un codice comune. Tra le passate generazioni la poesia epica fungeva da veicolo. Oggi l’antica poesia epica arriva veicolata dal teatro, che non tutti frequentano. Un libro sarebbe più comodo, meno costoso e più facilmente riproponibile. Del resto sono due modi diversi di fruizione. La poesia, veicolata dal teatro, se l’operazione è ben riuscita, viene fruita in una situazione medianica collettiva. Mentre letta, è giocata tutta sul pensiero e sull’emozione individuale delle parole. Si tratta di altro. Di una diversa alchimia. Vale chiedersi se per una società che vive sull’apparenza del collettivo e del sociale sarà importante recuperare l’io individuale su tempi meno duri. Recuperare la silenziosa dimensione della lettura pensata sulle cose. Come? Compito non facile. A chi affidarlo? Se penso alla risposta e ad un possibile interlocutore non li penso in astratto. Mi si affollano voci concrete e discordi, conclamanti all’unanimità. Non abbiamo più tempo per sciogliere i nostri pensieri annodati… Abbiamo altri spazi… I letterati sono degli emarginati… Da chi? Da Che cosa? Dal pudore atavico. Dalla paura di non essere accettati perché consapevoli delle sconfitte subite nel gioco dinamico di opposte filosofie. Dal timore di incontrarsi con la frettolosa indifferenza. La poesia esige attenzione perché merita rispetto. Ma dove trovare quegli spazi e quei tempi? Se ci fosse ancora un motivo valido per leggerla, potremmo guardare ai poeti non più come profeti di sogni utopici ma come uomini il cui occhio ferisce le cose per trapassarle e guardarci meglio dentro. Per scompaginare il comune buon senso e ricomporre equilibri, per entrare in quel “senso scontato”, rinsaldare nuove armonie. I lettori assenti dicono che il linguaggio non è sempre accessibile e che la poesia è per iniziati. Ma dove sono? L’iniziato è un predestinato al potere dell’ascolto. Abbiamo perduto anche questa capacità e con essa lo squisito colloquio della mente. Un colloquio senza parole, sulle parole. Un dialogo essenziale, sussurrato. Senza suoni, staccato dalla conflittualità del “verbo” per tornare ad essere parola – parlata, parola – espressa e di nuovo calata nelle cose da cui nasce il “distillato” attraverso il crogiolo del pensiero. La poesia potrà riconciliarci? Come? Attraverso che cosa? La generazione immediatamente dietro la nostra, poco scolarizzata, ricorda almeno un verso che ancor oggi recita con orgoglioso trionfalismo per affermare più una memoria inappuntabile che un modello culturale. I giovani di oggi hanno poca confidenza con il “fatto poetico”. Nel didattismo imperante tutto il tempo, o quasi, è assorbito da problemi ambientali o da micro-processori. Chi dovrebbe farsi carico, quindi, di scongiurare quella morte presunta? Una fabbrica di idee. Quale opportunità per la scuola! Ma ci vuole coraggio. Il coraggio di progettare, di confrontarsi, di essere protagonisti. Scuola come fabbrica. Scuola come laboratorio, laddove la ricerca diventa minuziosa e il confronto una condizione permanente. Laddove la parola si traduce nel gesto e il gesto si fa parola. Parola per indicare la cosa o per suggerirla. Parola giocata sul verso – rima o su una sottile metaforia discorsiva. Affidarsi di nuovo alla sua demiurghia! Parole che generano parole. Parole che generano cose. Innumerevoli metastasi del pensiero, portatrici di stereotipie destinate ad un rapido processo di mineralizzazione o di fermenti desiderosi di lievitarsi per indagare ed esplorare l’avventura. Laboratorio quindi della parola, pronta a rimodellarsi e a rifondersi in una caleidoscopia metamorfica. In questo spazio è possibile che nasca un nuovo ascoltatore. Se non ci fosse dato di pensare a tale possibilità, avremmo condannato non solo la vita futura dell’arte ma del pensiero. A scuola si impara a leggere e a scrivere di tutto. Si può educare o adulterare. Mistificare o mitizzare. Quale straordinaria iniziazione l’appropriazione del mito conquistato nel verso degli eroi, sul gusto della grande epica. Da tempo il “pass” è cambiato e così pure i miti, ma non l’aspirazione ad assolutizzarli. Solo che i nuovi ideali sono spesso modelli improponibili. E sugli altari c’è un vuoto di potere, un’assenza. Abbiamo tagliato fuori la grande epica classica perché c’è sembrato che fosse portatrice di un messaggio scaduto, troppo lontano nel tempo. Eppure quegli Dei hanno le stesse passioni degli uomini e giocano sulla politica delle alleanze. Con essa abbiamo liquidato anche quella musicalità e quel ritmo incomparabile dell’esametro dattilico. Se a scuola si tenta oggi un timido approccio poetico lo si fa sulla base dell’analisi testuale. Si viviseziona il tutto in parti che poi malamente si cerca di ricucire. Un’accurata analisi di laboratorio molto asettica. Si fratturano le immagini, il sottile gioco delle forme, il difficile equilibrio dell’armonia, il ritmo della strofa, le cadenze degli “a capo”. La poesia memorizzata, tanto spesso deprecata, recuperava quegli spazi e quei tempi scanditi ritmicamente. Creava un gusto. Credo che bisognerà riprovare con qualche verso, epico e non. Abbandonarsi alla lettura, così, semplicemente, senza altri obiettivi. Catturare i sensi e poi l’intelletto. Si creerà così una condizione di ricettività. Da qui la libera creazione. La poesia non è solo illusione, evasione, gioco. È anche denuncia, protesta, affermazione, negazione, provocazione. È un’avventura del pensiero, complice la parola, che esperisce tutte le sue possibilità al limite di sé stessa.